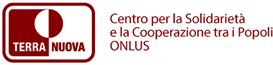Diritto al cibo: in Italia ancora non è una realtà

29 marzo 2019 - Una delle direttrici fondamentali del progetto italiano "Nuove Narrazioni per la Cooperazione", di cui Terra Nuova è partner, è quella della tutela e promozione del diritto al cibo. Si tratta di un diritto che in Italia diamo per scontato. La realtà racconta una storia diversa, e non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche nel nostro Paese. La prima volta che il diritto al cibo riceve un inquadramento giuridico ben definito è nel 1992, quando il Commento Generale numero 12 del Comitato per i Diritti Sociali, Economici e Culturali delle Nazioni Unite da una definizione degli obblighi che scaturiscono da esso. In particolare, le NU parlano di tre obblighi per gli Stati membri: "le obbligazioni di rispettare, proteggere e realizzare (facilitare e provvedere) il diritto al cibo."
Se è vero che diritto al cibo e sicurezza alimentare vanno a braccetto, il primo si pone in un contesto più ampio della seconda. Innanzitutto perché da un lato attribuisce obbligazioni giuridiche agli Stati, mentre dall'altro riconosce diritti agli individui o gruppi di persone. In secondo luogo, perché il diritto al cibo è strettamente connesso con altri diritti umani essenziali ed è suscettibile di essere violato anche in contesti che non siano di emergenza o in paesi in via di sviluppo.
Negli ultimi anni si sono moltiplicate gli strumenti a livello internazionale (norme, Dichiarazioni, Linee guida, ecc.) sul diritto al cibo. Basti citare le Linee Guida volontarie della FAO del 2004, oppure la Comunicazione europea dal titolo "Una Politica Europea per assistere i paesi in via di sviluppo ad affrontare le sfide relative alla sicurezza alimentare", adottata il 31 marzo 2010.
Tra norme e realtà
In Italia il diritto al cibo non è riconosciuto esplicitamente. Vi sono però alcune norme che implicitamente ne affermano il ruolo e ne impongono il rispetto. Innanzitutto, nella Costituzione sono elencati numerosi diritti direttamente associati con la garanzia di un sistema alimentare sostenibile, con la lotta alla povertà e con il diritto al cibo. Inoltre, vi sono norme costituzionali (art 11 e 117) che impongono il rispetto dei trattati internazionali che l'Italia ha firmato. Ne deriva perciò l'inserimento del nostro paese in un quadro legislativo internazionale che vuole tutelare e promuovere il diritto al cibo.
Proprio in Italia, però, moltissime persone vedono messo a rischio questo diritto. Un po' di numeri aiuteranno a capire la situazione. I dati ISTAT sulla povertà nel 2017, pubblicati a giugno dell'anno scorso, affermano che gli individui in stato di povertà assoluta sono oltre 5 milioni (+0,5% rispetto al 2016). La povertà viene calcolata in base ai consumi, appare perciò evidente la correlazione tra povertà ed alimentazione carente. Le categorie più a rischio sono le donne, i giovani e gli stranieri. Il 6,9% delle famiglie residenti in Italia non ha un adeguato accesso al cibo, né in termini di quantità né di qualità. A farne le spese sono soprattutto le famiglie con uno o tutti i componenti provenienti da paesi extraeuropei. Appare chiara la mancanza di un'azione incisiva dello Stato e degli enti locali, che sono tenuti per legge ad attuare delle politiche di integrazione che assicurino un adeguato accesso al cibo. A sopperire alle mancanze della macchina statale spesso ci pensano Onlus, Ong e associazioni (laiche o religiose), ma è chiaro che non è sufficiente. Per ottenere risultati concreti si dovrebbe partire da un cambio radicale di atteggiamento: non considerare il cibo solo come un bene da commerciare, ma un diritto da garantire. Da qui deriva la necessità di rivedere l'intera filiera produttiva partendo dalla terra per arrivare ai mercati.
Verso un mercato concentrato
A tal proposito, è importante rilevare come si dia sempre maggiore importanza e si conceda enorme influenza ai grandi produttori. Se si guarda ai numeri, però, si vede che in Europa i produttori che possiedono oltre 100 ettari di terra sono solo il 2,7%, mentre i piccoli e medi sono oltre il 97%. Secondo i dati Eurostat analizzati dalla FAO, le aziende agricole entro i 20 ettari producono cibo per 3.151.100.000 chilocalorie, mentre quelle oltre i 100 ettari si fermano invece a 1.846.100.100. Inoltre, bisogne considerare la concentrazione del mercato. Si calcola che le industrie di grandi dimensioni ne dominino oltre l'80%. Questo, unito alla scomparsa della metà delle aziende agricole di piccole dimensioni, implica la concentrazione di un potere enorme nelle mani di pochi, a scapito del diritto al cibo. La proposta per la PAC 2021-2027 prevede imponenti tagli allo sviluppo rurale (dai 10,43 miliardi attuali a 8,9). É chiaro che a risentirne di più saranno proprio le piccole e medie realtà.
A rischio la qualità del cibo
A questi problemi si aggiunge quello della qualità del cibo. Secondo i dati pubblicati dal "Sole 24 Ore" a maggio del 2018, a livello regionale le persone in sovrappeso sono il 31,7%, mentre quelle obese il 10,7%. L'equazione è questa: se si hanno minori risorse economiche si acquisterà cibo di minore qualità e con uno scarso valore nutrizionale. Da qui i fenomeni di cui sopra. Molto spesso, il cibo a basso prezzo presente in gran quantità sugli scaffali dei nostri mercati ha uno scarso valore nutrizionale e una qualità inadeguata. Emblematico di questa situazione il fatto che spesso l'etichettatura del cibo non è completa: molte volte non sono indicati elementi importanti. Secondo Coldiretti, ad esempio, il 3,2% dei prodotti importati presenta tracce di residui chimici (alcuni trattai con il famigerato glifosate) superiori ai limiti consentiti.
Scuole e lavoro
Ci sono altri aspetti da considerare. In primo luogo, in Italia non sempre l'accesso al cibo è considerato un diritto universale. Basti citare il caso della mensa di Corsico, città vicino Milano. Nel 2015, il Comune emanò una direttiva con la quale negava l'accesso alla mensa ai bambini che non fossero in regola con la retta. I genitori fecero ricorso al Tar della Lombardia richiedendo il riconoscimento del diritto al cibo per i loro figli. Il Tar, però, non accettò la richiesta dei genitori. Caso simile a Lodi, dove nell'ottobre del 2018 vennero esclusi dalla mensa i figli di genitori non-comunitari. In questo caso, però, il Tribunale di Milano riconobbe l'esistenza di un atteggiamento discriminatorio e ordinò al Comune di tornare sui suoi passi. Ad oggi, ci sono alcune proposte di legge depositate per impedire nuovi simili episodi.
In secondo luogo, il diritto al cibo è connesso con le condizioni di lavoro. Secondo il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nel 2015 gli stranieri regolarmente impiegati nel settore dell'agricoltura erano 405mila. Secondo l'Osservatorio Placido Rizzotto, però, nello stesso anno erano circa 430mila i lavoratori "in qualche modo occupati in modo irregolare nell'agricoltura in Italia". Di questi, l'80% erano stranieri e il 42% donne. In sostanza, emerge un uso strutturale della manodopera in nero nel settore agricolo. Una distorsione che porta a casi come quello di alcuni appartenenti alla comunità Sikh che lavoravano nel mercato ortofrutticolo di Fondi (il MOF - il più grande e moderno centro italiano di concentrazione, condizionamento e smistamento di prodotti ortofrutticoli freschi). I lavoratori Sikh, per sopportare le dure condizioni di lavoro (fino a 14 ore al giorno per 3 euro l'ora), erano arrivati a masticare bulbi di papavero per non sentire la fatica. Nel 2017, inoltre, vi furono tre casi di decesso per overdose da eroina. La legge 199/2016 è stata approvata dal Parlamento per cercare di porre un argine al fenomeno del caporalato. Ancora però c'è molta strada da fare. Stesso discorso vale per i cibi importati, che spesso arrivano da paesi dove i lavoratori sono in condizioni di schiavitù. Un esempio: l'Italia nel 2017 ha comprato cacao dal Ghana e dalla Costa d'Avorio, entrambi considerati paesi considerati a rischio per l'utilizzo di schiavi nell'agricoltura, per un valore di 227 milioni di dollari.
La legge Gadda
Il nostro paese ha fatto un importante passo in avanti sul tema della sostenibilità alimentare con l'adozione, nell'agosto 2016, della Legge Gadda. Il nostro paese è stato il secondo in Europa a introdurre una norma esplicitamente volta alla lotta contro lo spreco alimentare. Oltre a prevedere incentivi per la raccolta e la donazione del cibo non consumato, la legge riconosce l'importanza della ricerca di prodotti che facilitino il riuso, dell'informazione sull'insostenibilità del sistema attuale, della sensibilizzazione verso pratiche corrette. Secondo quanto dichiarato proprio dall'onorevole Gadda in un'intervista, ad un anno dall'approvazione della legge la quantità di cibo destinata alla redistribuzione era aumentata del 21% rispetto agli anni precedenti. Sebbene non ci siano ancora numeri ben definiti, è chiaro il contributo positivo che la legge sta apportando. Si tratta comunque solamente di un primo passo verso una piena realizzazione del diritto al cibo in Italia. C'è ancora molta strada da fare.
Articolo realizzato utilizzando i dati del Centro Internazinale Crocevia.